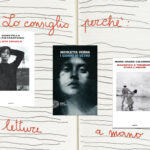Al centro dei tre libri che proponiamo c’è la straordinaria resilienza di donne, capaci di affrontare situazioni drammatiche e percorsi di affermazione con una forza che i ruoli abitualmente assegnati loro non permettono di far emergere.
Due di questi testi, La mia vita nel gulag, Memorie da Vorkuta 1945-1956 di Anna Szyszko- Grzywacz e Riaffiorano le nostre vite di Danya Breur, affrontano il tema della prigionia nelle strutture concentrazionarie, in un caso gulag sovietico e lager nazista nell’ altro. Riaffiorano le nostre vite racconta le vicende delle deportate nel campo femminile di Ravensbruck nel nord della Germania in cui sono transitate più di cento trentaduemila donne di ventitré paesi. La loro era anche la tragedia di circa mille bambini spesso nati nel campo e morti poco dopo.
La mia vita nel gulag è l’esperienza diretta di Anna Szyszko-Grzywacz che rimase per undici anni nel gulag di Vorkuta. Per singolare coincidenza, il primo è scritto dalla figlia di Aat Breur resistente e artista olandese internata che fortunatamente si salvò anche se gravemente malata. Nel campo di Ravensbruck c’erano donne di molte nazionalità europee di cui trentacinquemila, circa un quarto, polacche, figlie della disgraziata nazione smembrata tra Germania e Russia. Polacca è anche Anna di La mia vita nel gulag che detterà, ormai anziana, le sue memorie alla figlia.
Analoghe anche le narrazioni del loro internamento: il terrore, la fatica disumana, le vessazioni continue, la privazione di tutto ciò che rende vita la vita, l’incombente pericolo di morte. Si aggiungono sofferenze comuni e specifiche della condizione femminile : il timore e la realtà degli stupri, il parto e quasi sempre la perdita dei figli, l’essere spogliate di ogni pudore. Ma analoghe sono anche la capacità di resistere, la fedeltà alle proprie scelte politiche e morali, la solidarietà e il coraggio.
La protagonista di “La donna che odiava i corsetti” di Eleonora d’Errico, Rosa Genoni, cresce in condizioni certo non così drammatiche ma di sicuro difficili e sfavorevoli che sa affrontare e capovolgere con forza e determinazione enormi. Combatte battaglie private per diventare una sarta famosa e creare una moda tutta italiana, ma combatte anche indomite battaglie pubbliche in nome di un pacifismo radicale e per migliorare le condizioni di vita e lavoro di migliaia di donne
 Dunya Breur ,
Dunya Breur ,
Riaffiorano le nostre vite
ed Enciclopedia delle donne.it, 2023
Ravensbruck, vite riaffiorate.
Pochissimi conoscono la storia di questo campo di concentramento, il silenzio e l’oblio sono stati quasi totali, specie in Italia. Eppure è stato il campo di concentramento dove venivano portate le donne: esclusivamente rivolto alle sfortunate che venivano catturate dai nazisti nei loro costanti rastrellamenti.
Posto all’estremo Nord della Germania, all’entrata si poteva leggere non il noto e beffardo ‘ Il lavoro rende liberi’, ma il più diretto e atroce ‘ Qui spezzeremo la tua volontà’. I camini delle camere a gas, nel costante puzzo di carne e capelli bruciati, erano posti proprio all’entrata.
Di qui sono passate più di 132mila donne, ma questa è solo la cifra ufficiale riconosciuta: i nazisti hanno trascorso gli ultimi mesi prima della sconfitta finale a bruciare tutti i documenti, ed è facile dedurre che erano molte di più. Arresto e deportazione spesso distruggevano intere famiglie, e i pochi sopravvissuti a volte non trovavano più nessuno. Vi furono portati anche oltre mille bambini, quasi tutti passati per il camino. Ma le donne catturate erano in prevalenza giovani, e dunque nel campo nascevano in media circa 4 o 5 bambini al giorno.
In un primo tempo i nazisti avevano dato l’ordine di ucciderli subito, ma in seguito decisero di no: si erano infatti accorti che morivano entro pochi giorni lo stesso, per il freddo, la fame e l’impossibilità delle madri di accudirli a causa del lavoro coatto.
Gli appelli per il lavoro venivano fatti attorno alle 4 di mattina. Duravano ore, nel corso delle quali le detenute, vestite di stracci e pezzi di cartone rimediato alla meglio, erano costrette a stare in piedi al freddo con qualsiasi tempo. Nel giro di pochi giorni si ammalavano dunque quasi tutte, di bronchite, di polmonite e di tisi.
Ora un libro molto accurato, edito dall’enciclopedia delle donne e corredato dei bellissimi disegni fatti dalla madre dell’autrice, ne racconta la storia. E’ stato scritto da Dunya, la figlia di Aat Breur, artista dei tempi estremi e partigiana: all’epoca la piccola, nata nel 1942, aveva pochi mesi e si salvò perché le guardie del carcere dove all’inizio fu rinchiusa la madre, le permisero di avvisare i nonni che vennero a prenderla al portone del carcere di Utrecht prima della partenza di Aat per il campo.
Lei e il marito erano membri della resistenza olandese, e il padre fu fucilato nel 1943, poco dopo la cattura, Aat invece venne ‘allontanata’, termine con il quale si intendeva appunto l’invio nel campo, dopo un periodo di carcerazione.
Aat era olandese, dunque, secondo i tedeschi, ariana, ma lo stesso era nelle baracche ‘Notte e nebbia’ quelle destinate alle detenute che dovevano sparire nel nulla senza lasciare traccia di sé, secondo il programma dei carnefici, che intendevano tenere ben nascoste le prove dello sterminio. Una sorte ancora peggiore spettava alle ebree, alle russe, alle donne dell’Europa orientale e alle zingare, tutte considerate di una razza inferiore e in pratica destinate molto presto alle camere a gas.
35mila internate erano polacche, che in certi periodi costituirono circa un quarto della popolazione del campo. Fu soprattutto tra di loro, selezionate come cavie tra le più giovani e sane, che il medico personale di Heinrich Himmler, per di più anche presidente della Croce Rossa tedesca, fece alcuni atroci esperimenti medici.
C’erano anche molte prigioniere russe, arrivate nel febbraio del 1943: tante erano civili ma c’era anche un gran numero di soldatesse dell’Armata Rossa, che protestarono perché volevano essere trattate come prigioniere di guerra, secondo la Convenzione di Ginevra, e per questo furono giustiziate. Avevano rifiutato di lavorare nelle fabbriche di munizioni, e di cucire la lettera R sui vestiti per indicare la nazionalità, e avevano accettato solo le lettere SU (Sovietunion, Unione Sovietica). Il rifiuto di lavorare nelle fabbriche di munizioni fu punito in modo raccapricciante.
Le russe si distinguevano oltre che per la loro disciplina come gruppo, anche per forza fisica e resistenza al freddo.
Una di loro, la dottoressa Antonina Nikiforova, anatomopatologa, dovette eseguire autopsie e rimuovere organi cui erano interessati i medici delle SS. Nel campo i suoi capelli divennero completamente grigi. Dopo la guerra ha scritto le sue esperienze in un libro dal titolo ‘Dit mag zich niet herhalen!’( Questo non può ripetersi!), tradotto anche in francese (Plus Jamais!)
Nel campo c’erano anche molte prigioniere cecoslovacche, tante provenienti da Lidice, un villaggio sterminato e raso al suolo in seguito all’attentato a un ufficiale tedesco di alto rango. Accadde il 10 giugno del 1942.
Tra le tante donne ceche che morirono a Ravensbruck c’era anche Milena Jesenskà, che fu la fidanzata dello scrittore Franz Kafka durante gli ultimi anni della sua vita.
Era una giornalista intelligente e famosa, che aveva pubblicato molto su riviste prestigiose. Riuscì a salvare la vita di parecchie compagne di prigionia gravemente malate falsificando gli esami medici, perché lavorava negli uffici amministrativi. Morì lei stessa di malattia nel maggio del 1944.
Dopo tedesche, polacche e russe, erano le francesi il gruppo più numeroso del campo( più di 10mila). Provenivano da tutti i ceti sociali, dai gruppi della resistenza o arrestate come ostaggi e parenti di qualche membro della resistenza. Molte erano ebree. C’era più unità tra le francesi che tra le altre e insieme cantavano la Marsigliese ogni 14 luglio, sottovoce e appartate.
C’erano anche alcune donne implicate in Die Rote Kapelle ( L’orchestra rossa), rete di spionaggio guidata da un polacco che da Bruxelles, Parigi, Lione, Marsiglia e Berlino trasmetteva a Mosca messaggi di rilevanza militare. Finirono nel campo anche alcune paracadutiste francesi, tutte giustiziate tramite fucilazione.
In Francia sono stati pubblicati più libri su Ravensbruck che in qualsiasi altro paese.
Il campo fu liberato dall’Armata Rossa nel maggio del 45. Ecco come ne parla Aat Breur, che infine si salvò anche se dovette trascorrere molti anni in sanatorio: ‘Improvvisamente nel campo c’era un russo a cavallo. Era uno spettacolo surreale. Una delle ragazze russe gli andò incontro e apprese che le truppe si stavano avvicinando. Non potevamo davvero crederci. In realtà non eravamo più in grado di credere a nulla che fosse buono e piacevole. Ma poco dopo dei mezzi pesanti entrarono rombando nel campo. Carri armati russi! Era quasi da non crederci, mi viene ancora da piangere.’
I tedeschi fuggendo non avevano fatto a tempo a minare il campo per farlo esplodere.
Dopo la liberazione fu proprio la dottoressa Antonina Nikiforova a prendere la guida del campo. C’era sempre una enorme quantità di lavoro da fare. Molte prigioniere arrivarono quasi a credere che Antonina fosse una maga, perché trovava il modo di occuparsi personalmente di una moltitudine di piccole cose che rendevano la vita degli altri più sopportabile…
Delle 132mila prigioniere ufficiali, provenienti da 23 paesi diversi, 92mila morirono di fame e malattie e 32mila nelle camere e gas. Tuttavia, come si capisce dai racconti delle sopravvissute, i nazisti non erano riusciti a spezzare la loro volontà.
Valeria Fieramonte.
 Anna Szyszko-Grzywacz,
Anna Szyszko-Grzywacz,
La mia vita nel gulag – Memorie da Vorkuta 1945-1956
Guerini e associati, Milano 2024,
È raro avere testimonianze di detenuti polacchi nei gulag russi e ancora più raro che una donna ne sia l’autrice. Entrambe queste peculiarità sono presenti nel libro di Anna Szyszko-Grzywacz insieme a molti altri motivi di interesse. Il testo è stato dettato alla figlia da una Anna ormai anziana (morirà a cento anni nel 2023) e del linguaggio parlato ha il lessico e la forma: fresca, diretta e colloquiale. Lo scopo quindi non è tanto la denuncia politica quanto la narrazione testimoniale. Anna ricostruisce il senso del suo impegno, la tragedia vissuta grazie a una memoria vigile che sa restituirci anche dettagli vivi e preziosi per consegnarci l’unicità di una esperienza.
Tra le vicende narrate e la narratrice che le racconta, in una sorta di lascito storico e umano alla figlia, è intercorso molto tempo, ma certo non ha sbiadito la portata degli eventi. E’ cambiato profondamente il contesto storico politico del suo paese, la Polonia, e del mondo intero. Come è noto, nella seconda guerra mondiale la Polonia divenne vittima sacrificale del patto scellerato tra Germania nazista e URSS stalinista, entrambe odiate dai patrioti polacchi.
La resistenza nazionalista polacca fu sconfitta ma non cancellata e si articolò in varie formazioni. Anna entra nell’Unione dei liberi polacchi nel 1939 a sedici anni, come staffetta col nome di battaglia di Dana dopo che la Polonia del nord diventa zona d’influenza dei russi. Verrà arrestata dai servizi segreti sovietici nel 1945, alla fine della guerra, per aver militato con l’Armia Krajova, l’organizzazione militare della delegazione polacca del governo nazionale in esilio a Londra. Trasferita in URSS, dopo varie tappe di prigionia e una condanna a venti anni di gulag, viene internata definitivamente a Vorkuta.
Vi arriva nel pieno di dicembre: nel gelo indicibile, la accoglie un’aurora boreale. La vita che aspetta Anna come molti altri è fatta di fatica durissima, insensata burocrazia dai tratti kafkiani, vessazioni e privazioni, mancanza di cibo e di sonno paura e violenza. La paura dello stupro, individuale e collettivo (il tram) è costante. Colpisce profondamente che Anna parli con naturalezza delle sue immani fatiche, dando prova lei e le compagne di straordinaria resilienza. Attraverso le sue parole conosciamo i rituali, il gergo, le gerarchie, le regole, le divisioni e le aggregazioni nazionali di questo microcosmo infernale, in cui tuttavia per sopravvivere occorre ripristinare una parvenza di quotidianità.
Aiuta Anna e le altre l’estrema giovinezza e il desiderio di gioco e allegria che le anima nonostante tutto. Ma ancora di più è fondamentale l’amicizia che lega cinque ragazze polacche in particolare Anna e Wanda, un’amicizia che diventa più di un legame di sangue. E’ ciò che permette la sopravvivenza e ancora di più il restare “umane” aiutandosi, condividendo, proteggendosi. Questa forza permette di tenere vivo il senso di verità e giustizia che le anima. Come dirà un’altra testimone, Wiktoria Krasniewska, nel campo non si piange; laddove la sofferenza è al culmine, non si parla di sofferenza. Là dove si è perduto tutto si vuole solo vivere e vivere significa ridere e amare appena si può. Le ragazze fanno lavori durissimi compreso quelli della miniera, sfiorano ripetutamente la morte e si trovano fisicamente in condizioni orribili (vestite di stracci, senza scarpe vivono tra insetti e sporcizia), nell’impossibilità di scrivere alla famiglia. Eppure trovano sempre ingegnose soluzioni per rendersi la vita più sopportabile e creano persino legami affettivi con prigionieri polacchi.
Ma intanto le cose cambiano: attraverso le trasformazioni interne, percepiscono quelle esterne: Adenauer visita il campo e i prigionieri tedeschi vengono rilasciati. E finalmente nel 1956 la libertà anche per Anna e le sue amiche. Per loro, come per tutti i reduci di esperienze concentrazionarie, il ritorno tanto sognato, non è mai facile. Tuttavia le “Cinque Gemelle” riusciranno a vivere vite piene, sposandosi, facendo figli coltivando le amicizie e lasciando un testamento prezioso.
Marilena Salvarezza
 Eleonora D’Errico,
Eleonora D’Errico,
La donna che odiava i corsetti,
Rizzoli, Milano 2024
Ha la forma di un fluviale romanzo popolare La donna che odiava i corsetti, il libro che racconta la vita della sarta Rosa Genoni. Ma oltre ad essere fluente e scorrevole, il romanzo è ben documento e si è avvalso dei racconti preziosi dei familiari di Rosa che da anni ne promuovono la figura. Il romanzo, scritto in prima persona, è una lunga narrazione che la nonna fa alla nipote della sua vita, insieme eccezionale vicenda personale e spaccato di un’epoca. Nata a Tirano da una famiglia povera e numerosa nel 1867, Rosa viene catapultata a Milano a dieci anni, per lavorare nella sartoria della zia Emilia.
Il suo destino è quello delle “piscinine”, schiera di lavoratrici bambine tuttofare impiegate nelle sartorie sul finire dell’Ottocento. Milano è una città operaia in pieno sviluppo industriale e il settore tessile con tutto il suo indotto ne è uno dei traini. Il lavoro sartoriale tuttavia è puramente imitativo dello stile di Parigi, vera capitale creativa della moda.
Rosa scoprirà presto anche le durezze di una città in cui coesistono ricchezza e miseria; sfruttamento e repressione sono l’altra faccia dello sviluppo. Distinguono Rosa dalle sue coetanee un’intelligenza brillante, una curiosità insaziabile, un carattere determinato e indomabile. Caratteristiche che le permetteranno, nonostante le modeste condizioni di partenza, traguardi sempre più alti. Entrerà giovanissima in circoli politici socialisti, si trasferirà a Parigi e lavorerà in importanti case di moda francesi.
Al suo ritorno in Italia perseguirà con tenacia il suo obiettivo più ambizioso: creare una moda originale italiana, ispirata alla grande tradizione pittorica del nostro paese. Una moda più libera che abolisce i soffocanti corsetti ed esprime quindi una visione meno costrittiva delle donne. A capo di duecento dipendenti della Casa di moda Haardt e figli, prima in assoluto, espone il suo abito “Primavera” ispirato a Botticelli all’Esposizione Universale di Milano del 1906.
L’amore per la moda si intreccia inscindibilmente all’impegno politico-sociale al fianco di donne come Anna Kuliscioff e Anna Maria Mozzoni. Rosa sarà protagonista di coraggiose battaglie pacifiste, unica rappresentante italiana al congresso internazionale delle donne per la pace a l’Aia, nel 1915 in clima di guerra. Creerà nel 1905 e seguirà con passione presso le scuole professionali dell’Umanitaria di Milano un corso di sartoria e modisteria e più tardi anche di Storia del costume.
Per Rosa non si tratta solo di dare un mestiere a tante donne ma anche di renderle più emancipate, con una più spiccata coscienza di sé. Insegnò anche a San Vittore e numerose sono le sue pubblicazioni sulla storia della moda. La mole di impegni non le impedì una vita familiare e affettiva. Fece venire a Milano la sua famiglia d’origine ed aiutò genitori e fratelli. Dalla storia duratura con l’avvocato Podreider ebbe una figlia. Rosa Genoni è inserita nel suo tempo ma insieme lo oltrepassa e la sua figura è ancora significativa nel contesto attuale. Il libro di Eleonora D’Errico è davvero il romanzo di una vita colto anche nei suoi momenti di fatica, frustrazione e dolore. Un romanzo in cui si fondano macro e micro storia e si mescolano costruzione documentaria, immaginazione e invenzione sempre rispettose della realtà storica.
Marilena Salvarezza